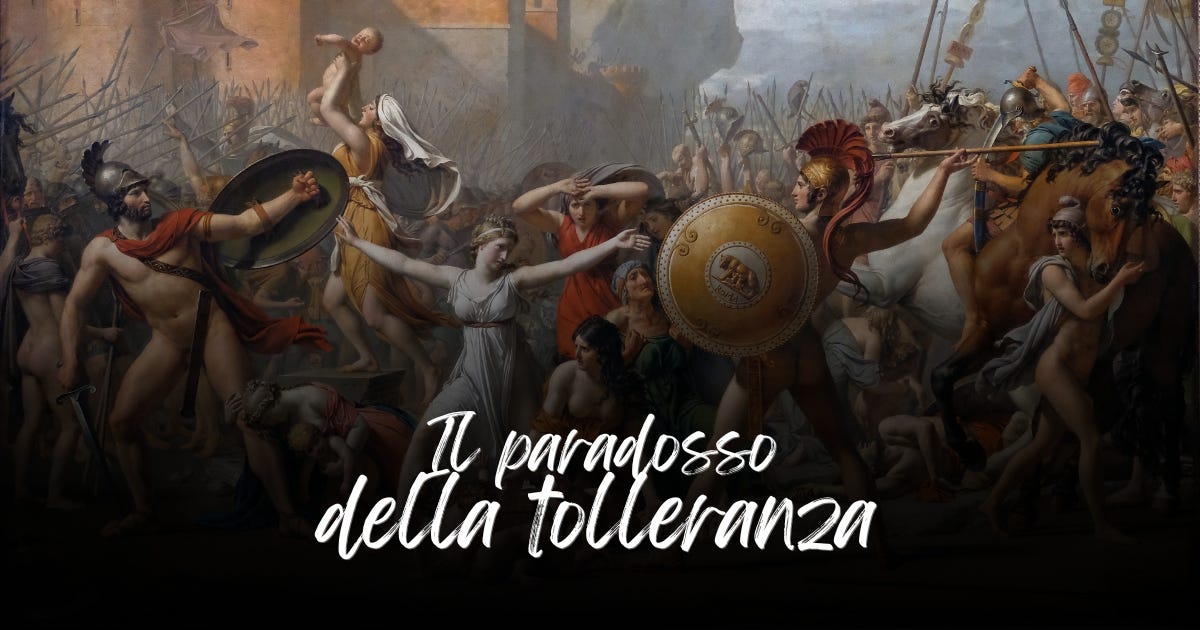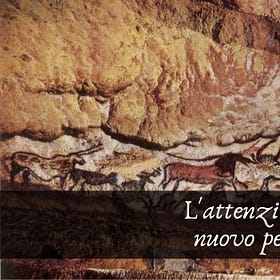Il paradosso della tolleranza
Se una società è tollerante senza limiti, la sua capacità di essere tollerante sarà infine distrutta dagli intolleranti.
Se ci guardiamo attorno sembra che i “cattivi” stiano vincendo un po’ dappertutto. In quasi tutti i Paesi coinvolti dalle elezioni, le frange estremiste guadagnano terreno, l’odio e il razzismo vengono normalizzati durante comizi sempre più popolari, e il linguaggio della politica ha raggiunto livelli di aggressività patologici. Di conseguenza, anche le persone si sentono libere di sfogare le pulsioni più bestiali, giustificate da slogan che accarezzano mefistofelicamente quelle stesse idee.
Cosa dovrebbero fare quelli che, come me, cercano di agire secondo un’etica ispirata alla tolleranza, al rispetto e alla ricerca della verità oltre la superficie propagandistica?
La prima risposta che mi è venuta in mente è uno dei dilemmi filosofici più affascinanti del secolo scorso: il Paradosso della Tolleranza di Karl Popper.
Il paradosso di Popper è, di per sé, un'opera di elegante semplicità:
Se una società è tollerante senza limiti, la sua capacità di essere tollerante sarà infine distrutta dagli intolleranti.
In breve: l’unica intolleranza ammessa è quella contro gli intolleranti. Perché essere tolleranti significa accettare e rispettare opinioni diverse, anche quando queste ci sembrano sbagliate o scomode. Ma cosa accade quando un'idea intollerante mette a rischio l'intero sistema? Popper non suggerisce che si debba sopprimere ogni voce dissenziente, ma piuttosto che si debba stabilire un limite. Quando una visione intollerante minaccia l'integrità della società, diventa necessario intervenire.
Facciamolo! - un attimo, prima contestualizziamo.
L’origine del paradosso
Popper elaborò questa teoria nella seconda metà degli anni ‘40, un'epoca segnata dalla recente memoria delle atrocità naziste. La Germania di Weimar, un esperimento democratico teoricamente robusto, aveva permesso al nazionalsocialismo di crescere e prosperare proprio grazie alla sua tolleranza verso un movimento che ne rifiutava i principi fondamentali. Questo tragico fallimento dimostrò che la tolleranza assoluta è, paradossalmente, insostenibile.
La lezione storica a cui si riferiva Popper è sicuramente efficace, ma se un paradigma funziona con il male assoluto di Hitler, non necessariamente deve funzionare allo stesso modo quando i confini si fanno più sbiaditi.
Il dilemma oggi
Nel dibattito contemporaneo, il paradosso di Popper è spesso evocato per giustificare l'esclusione di idee intolleranti dal dibattito pubblico. Tuttavia, questo approccio è problematico per almeno due motivi.
Il primo è semplice: come si decide chi merita tolleranza e chi no? Quali criteri utilizziamo per tracciare la linea di separazione tra la soppressione dell’intolleranza e la censura del dissenso? Rischiamo di trasformare la vittima in carnefice.
Il secondo è più subdolo: l’essere umano è attratto da ciò che è proibito. Più cerchiamo di sopprimere o proibire qualcosa, più quella cosa acquisisce fascino e forza, con il risultato di esaltare anche le voci più stronze che abbiamo sentito negli ultimi anni.
In ogni caso, mentre mi arrovello su queste seghe mentali, le ideologie estremiste e intolleranti conquistano fette sempre più grandi di popolazione, calpestano il dissenso (vedi Musk con Twitter o la recente querela del Ministro Valditara contro Nicola Lagioia) e alimentano paure e insicurezze grazie a una narrazione dalla semplicità disarmante: il mondo è diviso tra "noi" e "loro". Loro (immigrati, burocrati, gay, banchieri, intellettuali…) sono il nemico, e sono i responsabili dei tuoi problemi.
So what?
Non è un caso se la parola dell’anno, secondo l’Oxford Dictionary, è brainrot: marcescenza cerebrale o l’incancrenimento delle funzionalità cognitive come conseguenza di un esposizione massiccia a contenti di basso valore e di zero complessità.
Eppure, anche il termine brainrot, che sembra descrivere perfettamente la contemporaneità, non è affatto nuovo. Compare per la prima volta alla fine dell’Ottocento, coniato da Henry D. Thoreau, nel contesto di una riflessione sulla condizione umana e sulla deriva della società del suo tempo. In un’epoca che immaginava già in declino, Thoreau scorgeva segnali di "marcescenza mentale", quella stessa inclinazione a ridurre il pensiero complesso a schemi semplici e confortanti.
Ma pensaci: se un uomo di cent’anni fa osservasse il nostro presente, sarebbe letteralmente strabiliato dai giganteschi passi fatti verso la bellezza, la scienza, l’arte e la libertà.
Il progresso non è lineare. Ogni epoca ha i suoi spettri e i suoi profeti di sventura, ma ciò che emerge dalla storia è che l’essere umano trova sempre un modo per migliorare le cose.
Non ho la soluzione per sconfiggere il male dalla storia, e non so ancora come faremo ad abbassare il volume frastornante del dibattito in cui siamo immersi, ma sono abbastanza sicuro che tra cent’anni vivremo in un mondo migliore del nostro.
Da parte mia continuerò, anche attraverso questa newsletter, a piantare semini di consapevolezza e complessità; perché la realtà è complessa, i desideri e le paure sono complessi, l’identità è complessa, la verità è complessa.
Dall’archivio di Trasumanare
Ascoltami molto bene
In quale momento storico ti piacerebbe andare, se potessi viaggiare nel tempo?Quando me lo chiedono, rispondo che sicuramente vorrei partire dal Neolitico, circa 17.000 anni fa, insieme ai cacciatori…
Paradosso dell'abbondanza
Non vi è dubbio che la nostra sia, sotto ogni punto di vista, la più abbondante di tutte. Prodotti, cibo, ricchezza, energia (con l’eccezione del conflitto ucraino), possibilità...
Tre qualità che dovresti sviluppare come individuo
Nella vita ci capita di fare una serie infinita di errori grossolani, ma talvolta inciampiamo in grandi rivelazioni.