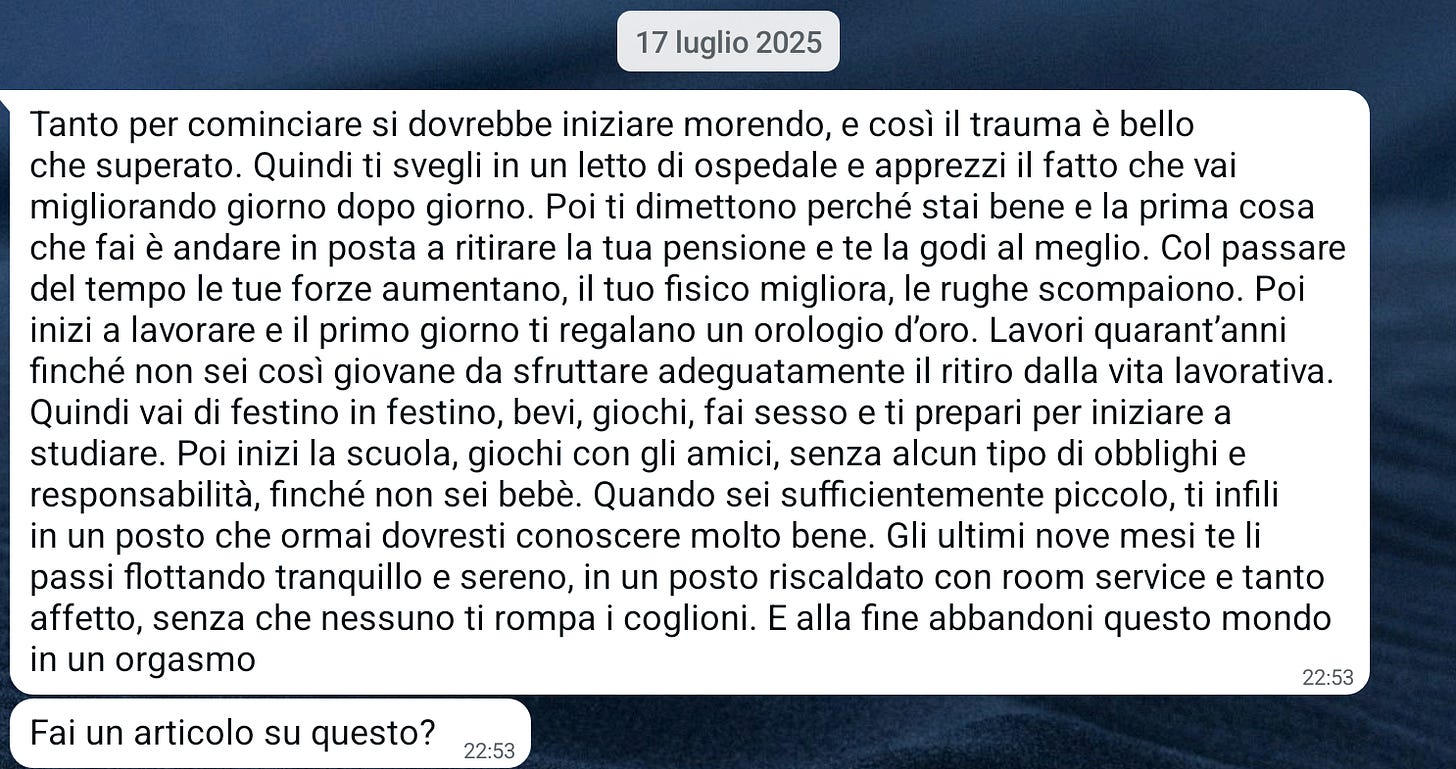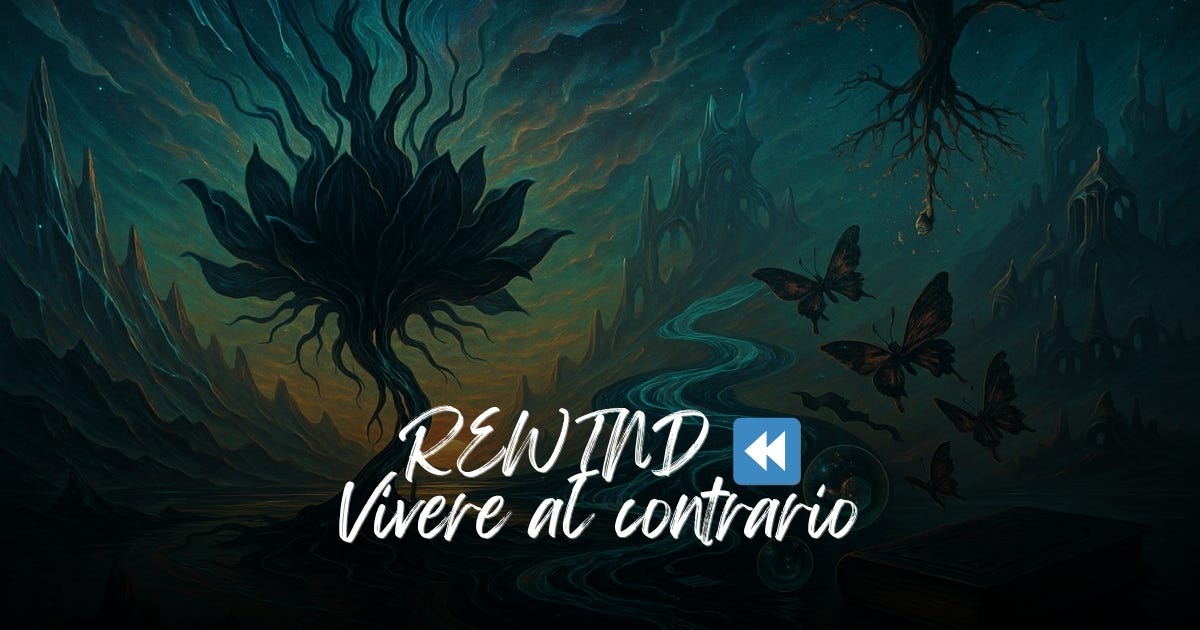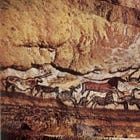REWIND ⏪ Vivere al contrario
Vivere al contrario: dalla morte alla nascita. Un esperimento mentale che ci insegna ad amare la vita così com'è, vecchiaia compresa.
Qualche sera fa ho ricevuto questo messaggio da un lettore di Trasumanare. È una rivisitazione di un’intervista a Woody Allen, in cui ironicamente esprimeva il medesimo concetto.
Una vita rovesciata. Una sorta di esistenza "in rewind", in cui invece di nascere e invecchiare, si parte dalla fine – dalla morte – e si procede a ritroso, diventando sempre più giovani, sempre più spensierati, fino a dissolversi nell'estasi primordiale dell'utero materno.
Ho deciso di raccogliere la sfida, non cercando di fornire le evidenze biologiche dell’impossibilità di un tale scenario, ma piuttosto trattandolo come un esercizio filosofico, sofistico. Mi sono divertito parecchio.
Quello che segue è il risultato di questo gioco dialettico.
Oltre alla suggestione sarcastica di Woody Allena, non è un'idea del tutto nuova. È stata già esplorata dalla letteratura e dal cinema, spesso con risultati inquietanti e profondi.
Nel 1991, Martin Amis pubblica Time's Arrow, un romanzo in cui la vita del protagonista si svolge interamente al contrario. Si parte dalla morte per risalire fino alla nascita, ma il punto di vista narrativo è interno: un "io" cosciente osserva, impotente e confuso, gli eventi che si svolgono all'indietro. Amis porta il lettore all'interno della mente di un ex medico nazista, e qui la magia nera del tempo rovesciato si rivela in tutta la sua potenza perturbante. Le azioni più atroci – la sperimentazione sui prigionieri, i campi di concentramento – sembrano, in questo strano mondo al contrario, delle miracolose guarigioni: i cadaveri tornano in vita, i corpi si ricompongono, le ferite si rimarginano. Il senso morale viene capovolto con violenza. L'orrore si maschera da salvezza. È un esperimento estremo di alienazione narrativa che ci costringe a confrontarci con l'ipocrisia delle nostre certezze etiche.
Poi c’è il celeberrimo The Curious Case of Benjamin Button, pubblicato da F. Scott Fitzgerald nel 1922. Lo conosci sicuramente già molto bene: il protagonista nasce vecchio e ringiovanisce col tempo, e alla fine Button (nato vecchio) diventa neonato, senza memoria, incapace di riconoscere anche le persone più care, condannato a morire nell'oblio totale.
Questi esempi ci mostrano che l'idea di vivere al contrario risulti inizialmente affascinante e si fa via via più disturbante. Ma che cosa implica davvero, se la si prende sul serio dal punto di vista filosofico?
Le frustrazioni dell’essere umano
Il messaggio del lettore trasforma in narrazione ironica alcune delle frustrazioni più universali dell'esperienza umana:
Il trauma della morte, elegantemente rimosso in apertura e relegato a un ricordo lontano.
Il corpo che si deteriora inesorabilmente, magicamente ribaltato in un miglioramento continuo.
Il lavoro come fatica e alienazione, trasformato in un percorso verso la leggerezza.
La vecchiaia come lento declino, reinventata come apice del piacere e della libertà.
In questo mondo capovolto, la responsabilità diminuisce progressivamente nel tempo, e la vita si conclude nel massimo dell'estasi piuttosto che nell'angoscia dell'agonia. È un ribaltamento radicale delle gerarchie esperienziali: anziché imparare a morire come ci insegnava la filosofia antica, impariamo a vivere sempre più spensieratamente, fino all'oblio beato. È l'utopia dell'infanzia perpetua, il sogno segreto di ogni adulto stanco.
Ma possiamo davvero prendere sul serio questo scenario? E soprattutto: avrebbe davvero più senso vivere così?
L’esistenza in quanto tempo
Una prima critica strutturale a questa fantasia ci viene da Martin Heidegger, il filosofo tedesco che in Essere e Tempo ci ricorda una verità fondamentale: l'esistenza umana non è semplicemente collocata nel tempo come un oggetto in una scatola. L'esistenza umana è tempo.
Heidegger chiama l'essere umano "Dasein" – letteralmente "esser-ci" – proprio per sottolineare che noi non siamo entità statiche, ma processi dinamici che si definiscono attraverso il loro rapporto con il tempo. E questo rapporto è orientato: ci proiettiamo costantemente verso il futuro, verso le nostre possibilità, verso i nostri progetti. La famosa frase heideggeriana suona così:
"L'uomo è un essere-per-la-morte."
Questo non significa vivere nell'angoscia costante o essere ossessionati dal pensiero della fine, ma riconoscere che è proprio il sapere che la vita ha un termine a renderla autentica e significativa. È la finitezza che dà peso alle nostre scelte, urgenza ai nostri progetti, intensità ai nostri amori.
Se la vita procedesse all'indietro non ci sarebbe vera tensione progettuale, nessun telos, nessun compimento da raggiungere. L'esistenza diventerebbe puro consumo del passato, un esercizio di nostalgia perpetua senza direzione né scopo. Saremmo condannati non alla libertà, come diceva Sartre, ma alla regressione. E la regressione, per quanto possa sembrare piacevole, non è vita autentica.
La freccia del tempo: fisica e coscienza
Ma anche la fisica moderna, non solo la filosofia, ci ricorda che il tempo non è reversibile nel senso profondo. La seconda legge della termodinamica stabilisce che l'entropia – il disordine – tende sempre ad aumentare in un sistema isolato. Questo principio fondamentale è ciò che crea la "freccia del tempo", la direzione irreversibile degli eventi nell'universo.
Come spiega con eleganza Carlo Rovelli nel suo L'Ordine del Tempo, il tempo è in realtà un effetto della nostra ignoranza, della nostra posizione parziale e limitata nel mondo. Noi ricordiamo il passato e non il futuro proprio perché viviamo in un universo in espansione entropica, dove l'informazione si disperde e il disordine aumenta. La memoria stessa è possibile solo grazie a questa asimmetria temporale.
In un universo fisico dove gli eventi scorrono secondo la freccia dell'entropia, l'invecchiamento non è un difetto da correggere, ma il modo stesso in cui il cosmo funziona. Ribaltare la direzione temporale significherebbe annullare le leggi fondamentali della fisica, creare un universo impossibile dove l'energia si concentra anziché disperdersi, dove l'informazione si ricompone anziché frammentarsi.
La vecchiaia, vista da questa prospettiva, non è un bug del sistema biologico, ma una conseguenza inevitabile e necessaria del fatto stesso di esistere in un universo governato dal tempo irreversibile.
La questione morale: senso, scelte e responsabilità
Un ulteriore nodo filosofico cruciale è la questione del senso esistenziale. Come osservava lucidamente Albert Camus ne Il Mito di Sisifo, nella condizione umana c'è un elemento irriducibile di assurdo. Siamo esseri coscienti e desiderosi di significato, ma destinati a morire in un universo apparentemente indifferente. Desideriamo permanenza e continuità, ma viviamo nel cambiamento e nella perdita costante.
Eppure, è proprio questa contraddizione tragica a renderci liberi e responsabili. È il peso dell'esistenza, la sua difficoltà intrinseca, la sua natura problematica che ci costringe a scegliere, a impegnarci, a creare significato dal nulla. Se la vita fosse un percorso prestabilito al contrario, con sempre meno responsabilità e sempre meno sforzo man mano che si procede, ci sarebbe davvero qualcosa di autentico da decidere? O sarebbe solo una lenta caduta nel compiacimento e nell'irresponsabilità?
"Bisogna immaginare Sisifo felice," scrive Camus nella conclusione del suo saggio.
Non perché la sua vita sia facile o piacevole, ma perché, nonostante l'assurdo della sua condizione, egli accetta di portare il masso su per la montagna, ancora e ancora, con piena consapevolezza. È questa accettazione lucida della difficoltà che rende l'esistenza autentica e degna di essere vissuta.
Una vita al contrario eliminerebbe questa dimensione eroica dell'esistenza, riducendola a puro edonismo regressivo.
Rivalutare la vecchiaia
La nostra società della performance ci spinge a dipingere implicitamente la vecchiaia come una condizione infelice, segnata da debolezza, solitudine e declino. Ma questa è solo una delle prospettive possibili.
Già Cicerone, nel suo De Senectute, offriva una difesa appassionata della vecchiaia come età della saggezza e della libertà dagli impulsi distruttivi della giovinezza. Scrive:
"La vecchiaia sottrae gli uomini alle passioni che li accecano, e li restituisce finalmente alla ragione."
Per Cicerone, l'età avanzata non è diminuzione ma purificazione: ci libera dalle illusioni della gioventù, dalle ambizioni smodate, dai desideri che ci divorano. È l'età in cui finalmente possiamo vedere le cose come stanno davvero.
Anche Seneca, nelle sue Lettere a Lucilio, invita a prepararsi alla vecchiaia come a un raccolto prezioso: ciò che abbiamo seminato nella vita – amicizia autentica, studio appassionato, integrità morale – ci ritorna sotto forma di quiete interiore e saggezza stoica. La vecchiaia ben vissuta non è impoverimento ma concentrazione dell'essenziale.
Più vicino a noi, Carl Gustav Jung parlava della seconda metà della vita come della fase cruciale dell'"individuazione": l'integrazione del sé profondo, della propria ombra, dei significati rimossi o trascurati. Non più costruzione esterna frenetica – successo sociale, accumulo di beni, affermazione dell'ego – ma lavoro interno di comprensione e riconciliazione con se stessi.
Questa prospettiva junghiana è particolarmente interessante perché non propone un ritorno nostalgico all'infanzia, ma un movimento in avanti verso il compimento del percorso individuale. La vecchiaia diventa così non la negazione della giovinezza, ma la sua maturazione e il suo superamento.
L'illusione della regressione e il desiderio di fuga
Bisogna interrogarsi onestamente sul desiderio implicito nella fantasia della vita al contrario: non è forse, in fondo, un desiderio di regressione? Il sogno di una esistenza rovesciata è anche il sogno di liberarsi progressivamente dalla responsabilità, dal lavoro, dai legami impegnativi, dai doveri che ci pesano. Ma questa non è libertà autentica.
Friedrich Nietzsche, nella sua critica feroce alla "morale del risentimento", avrebbe probabilmente letto in questo desiderio una manifestazione di "spirito reattivo": un rifiuto della durezza costitutiva dell'esistenza, travestito da ingegnosità narrativa. Per Nietzsche, la vita autentica richiede non la fuga dalle difficoltà, ma la loro trasformazione in occasioni di crescita e autoaffermazione.
Il concetto nietzschiano dell'"eterno ritorno" (a me molto caro) è particolarmente rilevante qui. L'eterno ritorno non è una teoria cosmologica, ma un test esistenziale: saresti disposto a rivivere la tua vita esattamente così com'è, con tutte le sue sofferenze e contraddizioni, infinite volte? Solo chi può rispondere "sì" a questa domanda ha davvero abbracciato l'esistenza.
Una vita al contrario fallirebbe questo test, perché rappresenterebbe il desiderio di modificare retroattivamente l'esperienza, di renderla più facile e piacevole. Ma questo significherebbe non averla mai davvero accettata.
Un vino maturo da apprezzare
Per quanto sia intellettualmente affascinante l'idea di vivere al contrario – e lo riconosco come un ottimo esercizio di immaginazione filosofica – credo che la vita sia giusta e bella così com'è.
Mi piace pensare che la vecchiaia non sia la rovina della giovinezza, ma la sua naturale maturazione. È il tempo in cui, se si è vissuto con consapevolezza e impegno, si può finalmente rallentare senza sensi di colpa, osservare con distacco, comprendere con profondità. È il tempo in cui si raccolgono i frutti seminati con pazienza, si custodiscono i legami autentici sopravvissuti alle tempeste, si contemplano i paesaggi interiori costruiti in decenni di esperienza.
Ogni stagione dell'esistenza ha le sue gemme nascoste. Quella della vecchiaia, per chi ha il coraggio di attraversarla con lucidità e dignità, è la pace operosa, come direbbe Tiziano Terzani: non l'inerzia, ma un'attività finalmente liberata dall'ansia del risultato. È la possibilità di essere invece di dover sempre diventare.
⚠️ Questo agosto non interromperò le pubblicazioni. Adoro scrivere e quale momento migliore, per te che leggi, di goderti le prossime uscite in spiaggia, in montagna o su un treno asiatico costeggiato dalle palme al tramonto?
Metti un like ❤️ fai un restack e condividi questo progetto, mi è di grande aiuto :)