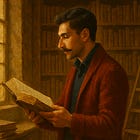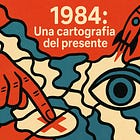Il mondo è perfetto così com'è?
Come conciliare contemplazione e responsabilità sociale di fronte alle ingiustizie del mondo? Una comparazione filosofica tra non-dualità orientale e giudizio critico occidentale.
Quella che stai leggendo è l'evoluzione filosofica del precedente numero su cosa fare, concretamente, per Gaza. È come se avessi riflettuto a lungo sulle motivazioni profonde che stanno alla base dell'agire umano, soprattutto in questo momento storico che non esito a definire epocale, perché di questo, in fondo, si tratta.
Ti avverto: il testo di oggi è piuttosto lungo e impegnativo. Dedicagli qualche minuto in più del solito :)
Io, che ormai passo buona parte della mia vita a insegnare meditazione e consapevolezza, mi ritrovo inevitabilmente a dover fare i conti con una domanda che mi logora: come conciliare davvero la pratica spirituale con la realtà cruda, innegabile, del presente schizofrenico che stiamo vivendo? Come non cadere nella tentazione, così umana e comprensibile, di chiudere gli occhi in nome di un presunto distacco contemplativo, e al tempo stesso come non lasciarmi completamente divorare dalla rabbia, dal dolore lacerante, da quella sete di giustizia che a volte sembra l'unica cosa che ci rimane?
Come fosse una disputa sofistica ambientata nella mia testa, ho delineato due modi di guardare al mondo, entrambi legittimi nella loro radicalità, entrambi profondamente radicati in secoli di pensiero umano.
Da una parte, la visione contemplativa che ci invita con dolce fermezza a sospendere il giudizio e a considerare il mondo perfetto così com'è. Dall'altra, la prospettiva critica e trasformativa che ci spinge invece ad agire e combattere, nella convinzione profonda che il corso della storia non sia affatto immutabile, ma che attraverso le nostre scelte, piccole o grandi che siano, possiamo orientarlo verso una maggiore giustizia. Se sarò all'altezza del compito che mi sono dato, capirai quanto non sia questo un dilemma superficiale ma anzi la matrice stessa, il nucleo pulsante del nostro agire nella realtà.
La tesi: il mondo è perfetto così com'è
Questa posizione, che a prima vista può apparire scandalosa o ingenua, è in realtà profondamente familiare alle grandi tradizioni contemplative orientali: lo Zen con la sua paradossale saggezza, l'Advaita Vedānta con la sua metafisica dell'unità, la corrente del Buddhismo Mahāyāna con la sua compassione infinita. Tradotto in parole povere, questo atteggiamento significa qualcosa di molto preciso: smetti di giudicare continuamente, osserva le cose così come si manifestano nella loro nuda evidenza, riconosci che ogni fenomeno, anche il più doloroso, è espressione dell'Uno – chiamalo pure Tao, Brahman, Dharmakāya. Questo atteggiamento non rappresenta affatto un'abdicazione morale, una fuga vigliacca dalle responsabilità, ma piuttosto un’indagine del reale vicina alle leggi quantistiche.
Le argomentazioni che sostengono questa visione si articolano lungo diverse linee di pensiero, ciascuna con la sua particolare forza persuasiva. Innanzitutto, quella che potremmo chiamare la non-dualità metafisica: se il reale ultimo è davvero uno e indiviso, come sostengono queste tradizioni, allora le divisioni che la mente produce incessantemente (soggetto e oggetto, bene e male, giusto e sbagliato) non sono altro che costruzioni relative, utili forse alla navigazione quotidiana ma illusorie dal punto di vista dell'assoluto. L'errore fondamentale consiste nell'identificarsi completamente con la parte - tra cui l’ego che crediamo di essere - e nel credere che questa parte sia realmente separata dal tutto. Visto da questa prospettiva, ciò che ci appare "imperfetto" è soltanto una manifestazione relativa, certamente utile alla dinamica complessiva della manifestazione cosmica, ma non definitiva.
Strettamente collegata a questa visione metafisica è la sospensione del giudizio come pratica di liberazione dalla sofferenza. Nel buddhismo più autentico, così come nello yoga classico, la sospensione sistematica del giudizio non è un esercizio intellettuale ma una vera e propria disciplina che calma la mente irrequieta, riduce progressivamente il desiderio e l'attaccamento che sono fonte di sofferenza, e soprattutto apre quello spazio di silenzio interiore che consente una visione diretta, immediata della realtà. Etichettare continuamente il mondo come buono o cattivo, giusto o ingiusto, non fa che rafforzare ulteriormente l'ego e perpetuare la sua fondamentale sofferenza.
Ma forse l'aspetto più sottile e interessante è quello che potremmo chiamare il paradosso dell'azione: se tutto è manifestazione dell'Uno, allora anche il nostro senso di urgenza morale, il nostro impulso politico, la nostra irrefrenabile volontà di migliorare le cose sono parte dello stesso ordine cosmico. Quindi, paradossalmente, anche l'azione trasformativa più rivoluzionaria non contraddice affatto la perfezione ontologica del mondo: è semplicemente una modalità particolare con cui l'Uno sceglie di esprimersi attraverso di noi.
L'antitesi: non è affatto tutto perfetto
Ma la tradizione filosofica occidentale, quella che parte da Kant e attraversa tutto il pensiero tedesco fino a Nietzsche e oltre, ci offre una prospettiva completamente diversa, mettendo il concetto stesso di giudizio sotto una luce radicalmente differente. Qui il giudizio non appare più come una mera condanna o un rifiuto emotivo, ma come quella facoltà fondamentale che collega piani diversi dell'esperienza – il fenomenico e il normativo, il sensibile e il razionale – e che soprattutto abilita, rende possibile l'agire etico e politico nel suo senso più pieno.
In Kant, e specificamente nella Critica del giudizio, il giudizio riflettente emerge come quella facoltà misteriosa e insieme indispensabile che media tra il mondo della conoscenza scientifica, governato dall'intelletto e dalle sue categorie, e il mondo della ragione pratica, quello della morale e della libertà. Il giudizio riflettente è precisamente ciò che ci permette di pensare una finalità nella natura senza dover ricorrere all'ipotesi dogmatica di un fine esplicitamente posto da un creatore, e da questa intuizione nasce l'idea cruciale che il discernimento intellettuale sia condizione imprescindibile per ogni etica che voglia dirsi seria. L'esperienza del sublime kantiano, dal canto suo, non è mai passiva accettazione: essa contempla sì la potenza schiacciante della natura, ma la mette immediatamente in rapporto dialettico con la dignità morale dell'uomo, spingendo inevitabilmente verso un senso crescente di responsabilità e di diritto morale, non certo verso la rassegnazione.
Hegel introduce poi una dimensione storica che complica ulteriormente il quadro: per lui la storia non è affatto un mero spettacolo di manifestazioni cosmiche immutabili, ma un processo drammatico e faticoso in cui la libertà si realizza gradualmente – attraverso conflitti dolorosi, contraddizioni laceranti, trasformazioni che costano sofferenza. Dire che tutto è perfetto "così com'è" rischia di negare questa storicità fondamentale, questa possibilità concreta di emancipazione che è il cuore stesso della condizione umana. Marx radicalizza questa critica spostandola sul terreno dell'analisi sociale: "I filosofi hanno finora soltanto interpretato il mondo in modi diversi; si tratta però di trasformarlo." L'accettazione metafisica della totalità rischia di trasformarsi in ideologia nel senso più sottile e pericoloso del termine, in una graziosa neutralità intellettuale che scarica sulle strutture sociali imposte, presentandole come naturali e immutabili, le sofferenze concretissime e evitabilissime degli esseri umani.
Nietzsche porta questo discorso alle sue conseguenze più estreme, frantumando definitivamente il sogno della riconciliazione a ogni costo: la capacità autenticamente umana di creare nuovi valori, di dare forma inedita all'esistenza, esige una volontà attiva, creatrice, non certo una dissoluzione mistica in un assoluto che cancella le responsabilità individuali. Infine, Hans Jonas e la sua etica della responsabilità ci mettono di fronte alle sfide inedite del nostro tempo: davanti alle nuove capacità tecniche che abbiamo acquisito (biotecnologie, armi di distruzione di massa, mutamento climatico), la sospensione sistematica del giudizio può assumere i contorni del crimine, perché il principio della responsabilità ci chiede imperiosamente di pensare alle conseguenze a lungo termine delle nostre azioni, e questo richiede giudizio critico, previsione razionale, intervento deliberato.
Cambiano davvero le cose? Perché agire accettando l'unità
Questa domanda, che può sembrare astratta, tocca una questione metafisica molto antica. Già Parmenide (500 a.C.) sosteneva che il cambiamento fosse solo illusione.
Io distinguo il cambiamento su due livelli. A livello assoluto, se l'essere ultimo è immutabile, le trasformazioni non toccano l'essenza; a livello relativo, strutture sociali, corpi, clima, istituzioni cambiano sensibilmente producendo sofferenza o benessere reali per gli esseri senzienti. Le "fluttuazioni" del mondo fenomenico non sono irrilevanti: costituiscono precisamente il campo dell'esperienza morale, l'arena in cui si gioca la partita dell'etica.
Anche concedendo la verità profonda della prospettiva non-dualista, ci sono ragioni forti e perfettamente coerenti per continuare a impegnarsi attivamente nel miglioramento delle condizioni di vita. La compassione come ponte tra i due livelli: molte scuole del Mahāyāna spiegano che la visione ultima della vacuità non cancella la responsabilità compassionevole verso gli altri esseri, anzi la libera dall'attaccamento egoico rendendo paradossalmente l'azione più disinteressata e quindi più efficace. Inoltre, le conseguenze rimangono materialmente reali: la fame che attanaglia milioni di persone, le guerre che devastano intere regioni, il riscaldamento globale che minaccia l'ecosistema terrestre non sono "nostre illusioni soggettive" ma fenomeni che incidono drammaticamente sul nascere, il vivere e il morire di persone vere. L'accettazione metafisica dell'unità ultima non toglie nulla alla concretezza brutale del danno e del dolore.
Infine, c'è una questione di autenticità personale: per chi dedica tempo ed energia alla meditazione, l'indifferenza etica può trasformarsi in una forma sottile ma corrosiva di incoerenza, mentre un praticante onesto deve imparare a vedere chiaramente la realtà relativa e a trasformarla in modo consono alla propria pratica spirituale.
Una sintesi pratica
La polarità che abbiamo esplorato non è una scelta binaria che ci costringe a scegliere da che parte stare. È invece non solo possibile ma auspicabile coltivare entrambe le attitudini, applicandole con consapevolezza. Immagina di avere due "occhi" diversi: l'occhio dell'accettazione che si coltiva attraverso la pratica meditativa, la sospensione del giudizio emotivo, lo sviluppo dell'intelligenza contemplativa per calmare il sistema nervoso e vedere con chiarezza; l'occhio del discernimento che si esercita attraverso l'analisi critica rigorosa, il giudizio riflettente, la prassi strategica per identificare le cause strutturali del danno e scegliere interventi efficaci.
Possiamo utilizzare alcuni criteri decisionali come algoritmo pratico per orientarci: quando c'è sofferenza evidente e immediata (violenza fisica, fame acuta, rischio di vita), l'obbligo morale di agire prevale su ogni altra considerazione. Se il problema è chiaramente sistemico e il cambiamento delle strutture può ridurre la sofferenza su larga scala, diventa doveroso intervenire politicamente. È fondamentale valutare con onestà la probabilità ed efficacia della nostra azione, considerando il rapporto tra impatto atteso e costi. Quando il rischio futuro è particolarmente alto (tecnologie, ambiente), il principio di prudenza chiede azione preventiva. Infine, se un'azione compromette radicalmente la nostra capacità di praticare compassione nel tempo, è saggio cercare soluzioni che bilancino impegno esteriore e cura di sé.
Sul piano operativo, questa sintesi si articola attraverso una pratica interiore quotidiana (meditazione formale per coltivare chiarezza e ridurre reattività), studio critico continuo per conoscere davvero le strutture sociali e le cause dei problemi, e azione strategica attraverso iniziative efficaci privilegiando sempre mezzi non-violenti. Thich Nhat Hanh e il suo Engaged Buddhism esemplificano perfettamente questa sintesi: una pratica spirituale che non si limita alla contemplazione solitaria ma si impegna attivamente nel mondo per alleviare la sofferenza e promuovere la giustizia sociale, dimostrando luminosamente come accettazione contemplativa e consapevolezza critica possano lavorare insieme in sinergia creativa.
Conclusione
La risposta alla domanda che dà il titolo a questo saggio è necessariamente paradossale: il mondo è "perfetto" in quanto manifestazione dell'unità ultima che tutto abbraccia e tutto comprende, e contemporaneamente è drammaticamente "imperfetto" sul piano fenomenico della sofferenza concreta e dell'ingiustizia quotidiana. Non si tratta di un problema logico da risolvere una volta per tutte, ma una tensione vitale da abitare con saggezza crescente, giorno dopo giorno.
Salverei due verità essenziali da questo lungo trip sofistico: sospendere il giudizio salva la visione, perché senza un lavoro interiore paziente che disinnesca le nostre proiezioni inconsce e la reattività automatica, l'azione politica più nobile rischia di degenerare in vendetta personale o sottile auto-sabotaggio. Ma altrettanto vero è che il giudizio informato salva il mondo: senza una pratica affinata di consapevolezza, senza analisi rigorosa delle cause e conseguenze, senza l'assunzione piena delle nostre responsabilità storiche, anche la compassione più sincera può facilmente ridursi a sentimentalismo inefficace.
La pratica matura, quella che davvero trasforma, è dunque necessariamente doppia: da un lato coltiva con disciplina la calma e la chiarezza interiore che nascono dal silenzio meditativo; dall'altro sviluppa con uguale disciplina gli strumenti raffinati di analisi, strategia e responsabilità etica che ci permettono di agire efficacemente nel mondo. Il vero "non-giudizio", quello che libera davvero, è quindi il frutto maturo di un giudizio che sia stato ben esercitato e affinato: non una rinuncia pigra alla mente e alle sue facoltà, ma una loro applicazione suprema al servizio del reale.