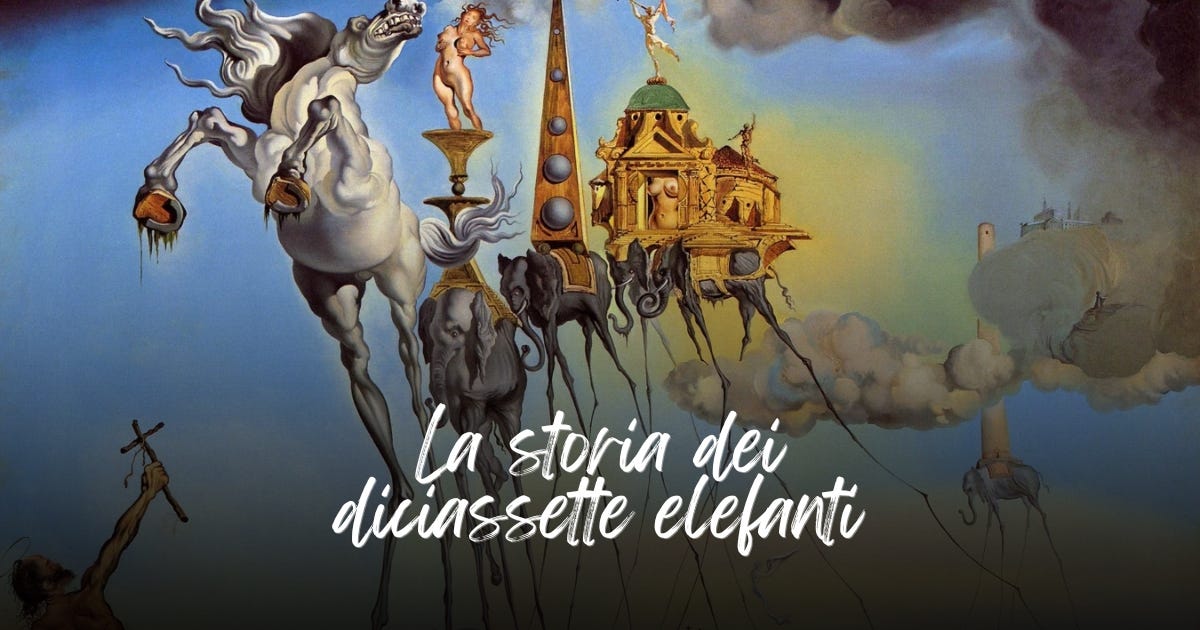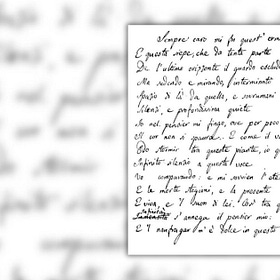17 elefanti 🐘 + 1
Una parabola indiana svela il segreto per risolvere l'impossibile: ciò che non possediamo ma che rende possibile tutto il resto.
Durante i primi giorni in cui vissuto nell’ashram SRSG di Rishikesh, in India, passavo le due libere ore dopo il pranzo a studiare libercoli presi dalla biblioteca, oppure a camminare nelle viuzze disseminate di fiori ascoltando audiolibri come la Bhagavadgītā o la Vita di Milarepa.
Dopo cena, durante le conversazioni informali con gli swami, facevo parecchie domande, spesso azzardando connessioni con filosofi e pensatori occidentali, alla ricerca di un punto di unione tra le pratiche spirituali tra l’est e l’ovest.
Volevo immergermi completamente nella meditazione: comprendere, decifrare, scoprire metodi e “segreti” per riuscire a farla meglio, applicando la solita modalità indagatrice e rabdomantica del cercatore di risposte europeo.
Sarà stato il quarto giorno, o giù di lì, quando uno swami vestito di arancione mi si avvicinò mentre ero seduto sulla panchina di fronte al mio cottage, intento a leggere: Mantra - What & Why.
“I want to tell you a story” e mi raccontò la storia dei diciassette elefanti.
Un ricco principe indiano, morendo serenamente, lascia in eredità i suoi diciassette elefanti ai tre figli. Nel testamento scrive: metà degli elefanti al primogenito Raj, un terzo al secondogenito Rahul, un nono al più giovane Sunil.
Il giorno del funerale, quando il testamento viene letto pubblicamente, i tre fratelli rimangono sbigottiti. Qual è la metà di diciassette? E un terzo? E un nono? I numeri non sono divisibili e il dilemma matematico sembra insormontabile.
“Ne prenderò io uno o due in più, che sono il primogenito!” tuona Raj.
“Dovremmo tagliarli a metà!” ribatte Rahul.
“No! Quelli che avanzano spettano a me che ne ho una minima parte!” supplica Sunil.
La lite si infiamma. I tre figli, un momento prima uniti nel dolore, rischiano di sfociare in una battaglia di successione. Sono pronti alle armi.
È in quel momento che arriva al funerale Deepak, vecchio amico del defunto, anch’egli principe di una regione vicina, uomo stimato per la sua saggezza. Cavalca un imponente elefante ornato di ghirlande, stoffe e pietre preziose, le unghie pitturate di rosa.
Quando comprende la ragione della baruffa, non dice nulla. Chiama le sue maestranze, si fa calare dall’elefante, e pronuncia poche parole: “Prendete in dono il mio elefante. Vedrete che riuscirete a dividere l’eredità come aveva indicato vostro padre, il quale era saggio almeno quanto me.”
I figli, increduli, accettano. E il calcolo diventa improvvisamente semplice:
La metà di diciotto: nove elefanti per Raj.
Un terzo di diciotto: sei elefanti per Rahul.
Un nono di diciotto: due elefanti per Sunil.
Totale? Diciassette!
Deepak sorride. “Ora che vi siete spartiti equamente gli elefanti, posso riprendermi il mio.” E se ne va, nel giubilo generale, festeggiato dalle lodi dei tre fratelli e di tutto il popolo.
Così come il principe Deepak, anche il mio swami arancione se ne andò, lasciandomi sospeso con la soluzione a un problema che non avevo nemmeno considerato. “Pranayama class will start within minutes, see you there”.
Credo che attraverso questa “parabola” il monaco volesse accompagnarmi verso la pienezza dell’esperienza, senza necessariamente arredarla di nozioni e concetti razionalizzanti. E in effetti, separandomi dal ruolo di “cercatore d’oro”, misi i panni del sommozzatore della coscienza, immergendomi nella pratica senza aggrapparmi più di tanto alla rassicurazione intellettuale.
Tuttavia, da quel giorno sono tornato diverse volte a ragionare su questa storiella, che a volte utilizzo anche agli studenti del mio percorso di meditazione. Il principio fondamentale è questo: il diciottesimo elefante è ciò che non si possiede ma che rende possibile tutto il resto.
Da questo semplice principio scaturiscono molteplici chiavi di lettura. Quelle che seguono sono le principali che ho individuato.
1. Livello esistenziale: la consapevolezza
Il diciottesimo elefante rappresenta la coscienza che osserva, è l’osservatore neutro dentro di noi. Quando siamo identificati con il problema, i conti non tornano mai. Quando aggiungiamo una separazione tra osservatore e osservato, all’improvviso tutto si chiarisce.
È il principio meditativo per eccellenza: la consapevolezza non prende parte, ma rende tutto comprensibile.
Ruoli, pensieri e passioni costituiscono l’esperienza umana, ma nessuna di queste dimensioni rappresenta il soggetto ultimo. Tutte si agitano dentro un campo più ampio: lo spazio della coscienza che ne è testimone.
2. Livello psicologico: la non-identificazione
I tre figli rappresentano le tre parti della psiche: la ragione, l’emozione, il desiderio. Nessuna riesce da sola a creare armonia.
Serve un quarto elemento (o un diciottesimo elefante): la capacità di trascendere l’identificazione con una di esse.
Jung avrebbe detto che questo livello è il Sé: non l’io che calcola e possiede, ma il principio unificante che tiene insieme gli opposti. I tre fratelli non possono risolvere nulla perché sono ancora intrappolati nella molteplicità delle funzioni psichiche. Solo quando entra il “dono” del saggio (simbolo del Sé, della totalità) le parti si ordinano spontaneamente. Il diciottesimo elefante, in questo senso, è l’irruzione del Sé nel caos della personalità frammentata: ciò che non può essere posseduto, ma che, una volta accolto, restituisce senso a tutto il resto.
3. Livello etico: la condivisione
Il problema dei fratelli non si scioglie con un calcolo, ma con un dono. Infatti, l’elefante prestato è un atto di condivisione incondizionata.
Spesso nella vita osserviamo questo fenomeno: ciò che si dona ritorna moltiplicato, ciò che si trattiene genera conflitto.
Il gesto del vecchio saggio non è razionale né conveniente: è un atto gratuito che scioglie un conflitto senza chiedere nulla in cambio. È la forma più alta di intelligenza morale: la saggezza che agisce per ristabilire l’armonia, non per ottenere vantaggio.
Per cui, eticamente, il diciottesimo elefante incarna il principio del dono non contrattuale, quello che supera la logica dello scambio e della reciprocità, ed è capace di rompere il ciclo chiuso del “mio” e “tuo”.
Qui si tocca il mistero (osservabile anche in economia) per cui l’abbondanza si crea condividendo.
Dov’è che servono “diciottesimi elefanti” ?
Ecco alcuni degli ambiti quotidiani in cui potresti andar cercandoli:
Nel lavoro: quando ogni analisi porta a un vicolo cieco, il “diciottesimo elefante” è l’intuizione, l’idea che non appartiene ai dati ma alla mente che li osserva.
Nelle relazioni: quando il calcolo di chi ha ragione o torto non porta pace, serve qualcosa che non appartiene a nessuno: l’ascolto reciproco, maggiore spazio, maggiore libertà.
Nella crescita personale: smettere di cercare la soluzione dentro la stessa logica che ha creato il problema. Serve un’ottava più alta, uno squarcio nel cielo di carta, una nuova prospettiva.
Nella meditazione: il diciottesimo elefante è il respiro. Non appartiene né al corpo, né alla mente, ma li unisce come un ponte.
Una citazione che ho letto nella newsletter del mio maestro di meditazione zen:
Il beneficio principale della meditazione, nei contesti dei normali alti e bassi della vita, non sta nell’impedire gli svantaggi e nel favorire i vantaggi, ma nell’indirizzare le persone verso la realtà fondamentale che non sottostà all’influenza degli alti e bassi. Muso Kokushi - 1300 d.C.
Ti è piaciuto questo post? Sarei felice se lo condividessi con chi lo amerebbe quanto te ❤️
C’è una differenza sottile ma fondamentale tra il sapere cosa ci fa stare bene e il praticarlo davvero, integrandolo nella nostra biologia.
Il percorso Breatheam nasce per colmare questa distanza. Ti guiderò attraverso un viaggio che intreccia antiche pratiche di consapevolezza con le più recenti scoperte neuroscientifiche. L’obiettivo non è aggiungere nozioni, ma togliere il superfluo e riconnetterti con le tue risorse interne attraverso l’esperienza diretta.
Se senti che è il momento di trasformare la tua vita con un metodo strutturato, parliamone a voce.
Dall’archivio di Trasumanare
Il naufragar m’è dolce in questo mare 🌊
In queste giornate rallentate, per molti ancora vissute con lo sguardo rivolto verso gli azzurri di cielo e mare che si accarezzano all’orizzonte, ho pensato di regalarti un momento di poesia, per ri…